Categorie: Arte e letteratura
Tags: I tesori di Guido Racconti storia antica tempo
Scritto da: Guido Ghezzi
Commenti:2
COELUM STELLATUM
Questo è il secondo dei "Tesori di Guido" raccolti nella sezione d'archivio ad essi dedicata
COELUM STELLATUM
di Guido Ghezzi
Tutto ciò che di buono e dolce vi è nella vita degli uomini,
inesorabilmente fluisce verso la città.
(Pericle)
Certo brevi confini ha il nostro tempo.
Scorgiamo i nostri anni e li contiamo.
Ma quale occhio mortale
Ha mai veduto gli anni delle genti?
(Friedrich Holderlin)
Hora prima*
Benvenuto dopo i passati giorni di cieli lattiginosi ed ardenti, solo un vento leggero e fresco restava della tempesta che la sera innanzi aveva a lungo battuto la costa.
Al termine della buona stagione i fortunali, ancora rari, colpivano con forza. Si annunciavano con stentoreo scuoter di nubi partorite dal ventre dei monti, in breve cresciute e quindi rotolate dal centro dell’isola verso l’arido pomeriggio della costa.
Il violento sgravarsi tra folgori e colpi di vento perdurò in quell’occasione fino a notte, lasciando dietro sé uno strascico di umidità e nebbie, gradito ai campi disseccati, temuto dalle viti gonfie di grappoli e inviso al logoro corpo del Governatore.
Con il repentino mutare del cielo era tornato il dolore.
L’indesiderato e affezionato ospite dei suoi ultimi anni era lì ad aspettarlo in compagnia dell’alba, solerte come un messo imperiale, avvolto nella tunica della vertigine, appollaiato sul denso pulsare delle tempie.
Avrebbe dovuto subire la mescita del brivido alla nuca con la pesantezza delle palpebre, la metamorfosi dell’ovattarsi sordo del presente nella morsa di bronzo dietro gli orecchi. Fino allo stremare lento dei prossimi giorni; fino a che il dolore se ne sarebbe andato, senza fretta diluito nel chiaro ristabilirsi del favore dei cieli.
Ma avrebbe fatto ritorno, incerto solo il momento di una nuova visita.
Dietro consiglio del buon medico Peonio continuava a tentare unguenti, sfortunatamente quasi tutti maleodoranti. Agli unguenti andavano alternati massaggi d’ortiche, tremendamente dolorosi, e scottanti cataplasmi di semi di lino. Ma, come Peonio aveva sapientemente avvertito, ogni rimedio sarebbe stato ben più efficace se accompagnato dal favore degli Dei.
Pur senza dubitare delle capacità del medico, ma reputando assai opportuno quest’ultimo ammonimento, da tempo il Governatore non mancava di manifestare agli Dei la propria considerazione, immolando ad Apollo ed Asclepio maialini da latte, polli e montoni.
* Affinchè i riferimenti temporali acquisiscano il corretto significato ma sussistendo al contempo una evidente discordanza tra le fonti, si riportano quelle che appaiono essere connotazioni certe in merito alla suddivisione del giorno nel mondo romano:
hora prima: inizia il giorno, coincide con l’alba;
hora sexta: il momento di culminazione del percorso giornaliero solare, la metà del giorno;
hora duodecima: finisce il giorno, coincide con il tramonto.
Così definita, la successione delle horae nella giornata del Governatore assume dunque significato relativo; al lettore l’onere di trasporre, ove ne avverta necessità, sulla base di questi soli cardini, la scansione temporale qui utilizzata entro i ferrei confini della moderna misura del tempo.
Ma per quale motivo i rimedi al dolore dovessero essi stessi per lo più causare in qualche forma altrui dolore e sofferenza, gli riusciva difficile da comprendere.
Forse il dolore mutava semplicemente luogo? Trapassava da un corpo ad un altro come in un immateriale traslocar di indirizzo?
Riflettendo in piedi sotto il portico, il Governatore misurò come abitudine la salute dell’orto al centro della grande casa. Nella mezza luce dell’alba vide che la tempesta aveva lasciato il segno. Foglie sul tetto e nella fontana, rami a terra, le piante scosse, un piccione stecchito in mezzo all’erba.
Allarmato si avvicinò per osservare meglio il corpo: un’ala ripiegata e l’altra stesa, le piume arruffate, il capo inerte e rivolto verso il vestibolo, gli occhi serrati così come il becco.
La testa candida spiccava di luce lunare nell’ombra ancora distesa sul giardino**.
Non un segno d’offesa sul corpo, solo la gelida compostezza della morte.
Considerò che il fatto andava segnalato all’aruspice senza esitare, la mattina stessa. Che fosse buon segno pareva piuttosto improbabile, ma forse poteva essere accadimento da non considerare. Quanto alla terza e assai meno desiderabile possibilità….meglio lasciare all’aruspice il suo mestiere.
I suoi pensieri furono interrotti da un confuso tramestìo proveniente dalla cucina. Rimase fermo davanti al piccione, con i piedi vellicati dall’erba fredda e umida. Trattenne un poco nella mente il silenzio dell’orto, ora profanato. Il tramestìo crebbe e mutò in trambusto, in uno sbatacchiare accompagnato da un vociare stanco e interrotto.
I veri padroni di casa incombevano.
Abbandonò rapido il giardino ed attraversò il grande triclinio. I domestici irruppero nella sala armati di ramazze, secchi e spazzoloni. Con gli occhi gonfi di sonno due di essi iniziarono a gettare acqua e spargere segatura sul pavimento. Altri, muniti di pertiche e spugne, presero a grattare le pareti, decisi a rimuovere anche il più rinsecchito dei ragni dal più remoto degli angoli della casa.
Vacillando per le vertigini si ritirò come un paguro intimorito nella camera della moglie, unico luogo realmente al riparo dallo zelante turbinio dei domestici. Almeno fino a che la padrona di casa non ne fosse sortita.
Azzia dormiva, incoronata da una disordinata selva di capelli grigi.
Nulla in lei poteva dirsi invidiato da Venere, molte parti del viso e del corpo contenendo un minuto difetto, un’incertezza delle curve, un’opacità nel fulgore. Tuttavia ogni dettaglio si componeva nell’armonia dell’insieme, quella misteriosa armonia che un giorno l’aveva resa così desiderabile ai suoi occhi.
Guardava a lei ancora come un tempo, considerando che l’incedere degli anni aveva sì intaccato la pelle, il viso, il ventre, gli occhi, ma non aveva potuto scalfire l’immateriale armonia dell’insieme, di quel tutto che era ben più della somma delle parti.
“Lo scorrere del tempo è elleboro per la bellezza, veleno per la giovinezza e non possiamo sottrarci dal bere a questa coppa, avara di un succo che lento ci distrugge” - questo amaro epitaffio ora vedeva scritto nei capelli scoloriti, nella pelle non più tesa, nella luce di tramonto in fondo agli occhi di Azzia.
Eppure non un solo giorno del loro lungo condividere il tempo aveva percepito alcunchè di mutato in lei. Nella voce un’incrinatura, nella pelle una traccia più fonda, nella curva del corpo una nuova incertezza: nulla, pur avendo cercato, era mai riuscito a cogliere con sicurezza.
Questa era la crudele sentenza: il tempo inesorabile dispensava il mutamento, ma impedendone la consapevolezza.
** La moderna sete di ordine che sembra costringere l’uomo a organizzare ogni cosa secondo geometrie e domini ben distinti non trova così estesa giustificazione nell’antica visione romana della realtà. Ortaggi, fiori, moti d’acqua, fronde fruttifere e plaghe d’ombra accoglievano il visitatore dell’hortus in un indistinto lembo naturale, un luogo in cui giardino ed orto unitari coesistevano.
Negando agli uomini la contezza del cambiamento, serbava il rendiconto per i giorni a venire, fino a che, nella luce incerta di una mattina, sollevava con gesto volgare e improvviso il velario.
In quell’istante prendeva corpo agli occhi umani il passato assommarsi di infinitesimi addendi, l’incorporeità del tempo assumeva la brutalità della carne e della materia.
Il sostenere questo impari confronto, questo impavido affrontare la lotta pur a dadi già tratti, questo incurante coraggio di Azzia nel subire i colpi dove più le erano dolorosi, lo riempiva di tenerezza.
E quel suo movimento, il modo che ella aveva di scorrere talvolta una mano sulle gambe o sulle braccia, un gesto lieve come il vergare di una goccia di pioggia su una foglia di acanto…. In quel gesto aveva sempre letto un avvertimento non proferito, un’ammissione di fragilità, un ammonimento al mondo ad essere discreto, a rispettare il suo sottile involucro e la sua anima di silente nevicata.
Nonostante la radula del tempo quel gesto si era conservato incorrotto negli anni. Come se non fosse il prodotto del moto del corpo di lei, ma piuttosto l’affiorare dell’armonia segreta del suo essere, di quell’armonia che attingeva alla fonte degli dei.
Insieme ai rumori la luce filtrava dalle altre stanze.
Per sfuggire a quella sensazione di fredda lama nella fronte, lama che Peonio non riusciva ad allontanare, il Governatore si spostò in modo da evitare che entrasse diretta negli occhi. Nell’ombra incerta distinse una tavoletta posata sull’arca presso il muro e si chinò ad esaminarla. Riconobbe l’invito che Azzia aveva mandato a Elpidia per la cena delle calende, elegantemente scritto dalla mano esperta dello scriba e poi firmato da Azzia, che aveva richiesto in aggiunta una decorazione a minuscoli fiori azzurri, pudicamente svolta ad abbellire la propria grafia insicura.
Hora quarta
Accompagnato dall’affermarsi della luce e dai rumori del giorno, il Governatore si ritirò come ogni mattina nel tablino per attendere ai soliti impegni: leggere missive, rispondere, studiare oziosi documenti, riflettere su ancor più oziose questioni.
Il dolore sordo non lo abbandonava e non lo avrebbe fatto per tutta la giornata, questo ormai gli era noto per consuetudine. Restava aggrappato alle sue spalle e premeva contro le palpebre. Solo la rotazione del capo lo fuggiva per un istante, costringendolo rannicchiato in un angolo del tablino, accanto allo scaffale con i volumi. Ma tornava, inesauribile come un tafano, pesante come un incubo, duro e livido come un gradino dei templi.
Con fatica e lentezza esaminò le molte missive sparse sul tavolo. Tra di esse una s’annunciò al suo occhio con esordio amichevole. Il senatore Rubio Statilio lo raggiungeva dalla sua villa ai piedi del colle Jano.
“Amico mio,
sapere che i fatti hanno gambe ben più leste delle lettere mi ha sempre messo a dura prova nello scrivere per trasmettere pensieri e riflessioni su quanto accade.
Per non incorrere in errate valutazioni si dovrebbe sempre guardare agli accadimenti con un occhio al domani e con l’altro a ieri. Uno strabismo che pochi sanno sostenere ed io non sono tra questi. E’ invece un grande sollievo scriverti sapendo di poter tralasciare ragionamenti circa gli affari di Stato o intorno alle dispute di cui si dibatte nelle aule di Roma.
Solo una considerazione mi permetto al proposito: i fatti possono essere spesso ingannevoli, ma certo assai meno delle parole; esse sono di materia tenera e modellabile, troppo facile per una lingua agile e sfrontata piegarle ad ottenere opposti effetti. E di tali lingue Roma trabocca. Altro non voglio aggiungere.
Per uno strano accidente m’è capitato di rammentare la vicenda del rospo sulla strada per Ostia, occorsa nel lontano tempo della nostra giovinezza. Certo ne conservi memoria anche tu, e certo ricordi le mille e più altre giornate che abbiamo condiviso negli anni dell’incoscienza.
Guardare oggi a giorni così lontani è come scrutare tra le nebbie, ogni cosa non solo ha contorni incerti ma fuggevole è anche l’immagine nella sua interezza. Solo la profondità con cui gli accadimenti si incisero allora nella nostra anima li rende oggi discernibili e riporta per un istante le sensazioni a incorrotta vividezza. Ma questo è vero solo per te e me.
I problemi che affliggono la tua isola (come altrimenti potrei chiamarla?) hanno simile natura: confini labili, forma ingannevole, e per di più grande lentezza nello svelarsi all’occhio umano.
Anche il più abile medico faticherebbe a trovare un rimedio per un male siffatto, se rimedio esiste.
Possano gli dei immortali essere al tuo fianco in tale improbo compito.
E’ amaro a dirsi: il mio cuore diviene pesante nel sapere la tua limpida rettitudine, il tuo strenuo impegno e il tuo giusto agire messi a così dura prova per una terra che Roma ha da tempo dimenticato.
Perciò ti esorto a non logorare i tuoi anni nell’oblio di una regione morente e questa mia villa possa essere la tua casa nei giorni futuri.
Sto bene se tu stai bene.”
L’accorato invito di Rubio richiedeva una sollecita risposta, ma la risposta medesima non poteva darsi senza una ben precisa decisione, la quale esigeva una attenta riflessione.
Tentò di raccogliere le idee ma fu subito distolto.
La pace ritornata dopo l’assalto dei domestici fu ancora una volta turbata da rapidi colpi battuti all’uscio, seguiti da un concitato assommarsi di voci.
Riconobbe tra esse quella del domestico Eusebio. Prestò attenzione alle parole. Distinse le ripetute esortazioni del domestico a fermarsi, ad attendere l’annuncio al padrone di casa. Sordi a tutto gli intrusi, due figure a lui ben note, irruppero nel tablino sollevando rabbiosamente la tenda, vanamente inseguiti da Eusebio. Il vecchio domestico si scusò per gli sgarbati ospiti e si ritirò chinando il capo raggrinzito, glabro e macchiato dalla senescenza.
Dei due rumorosi villani il Governatore non avrebbe saputo indicare il più agitato, facevano a gara nel prevaricare l’altrui voce rivolgendosi insulti ed accuse. Uno dei due era scalzo, dal corpo solido e dalla grande testa incorniciata da ricciute chiome, ignote all’attrezzo del tonsore. Sottobraccio reggeva un lurido involto. L’altro, più esile e nervoso, ben rasato e dalle mani curate ma con la tunica macchiata di sudore, dava l’impressione di essere uscito di casa in tutta fretta.
Il Governatore appoggiò le mani sul tavolo. Il mal di capo magnificava ogni rumore rendendolo doloroso, le voci urtavano con spigolo vivo sulle tempie, la luce filtrava dal lucernaio all’apparente solo scopo di trafiggergli il fondo dei bulbi oculari.
- Le disgrazie è raro che si presentino sole… - pensò.
Quei due erano quanto di peggio avrebbe desiderato in quel mattino così gravato dal malessere.
Di tutti coloro che avrebbero potuto chiedere udienza (costume che essi avevano ritenuto di non dover rispettare) il colono Trofio, temibile campione di scaltra rozzezza e il liberto Velliano, tediosa somma di puntigliosità e avarizia, erano i cittadini più perniciosi che solo il Fato beffardo poteva accomunare quel giorno nella sua casa.
Il corpulento Trofio aprì l’involto, ne trasse un orecchio di maiale sanguinolento e lo sbattè sul tavolo. Il liberto Velliano fece un passo indietro con un moto di ribrezzo. Il colono gonfiò il petto e pronunciò la formula di rito - Io, colono Trofio…. -
Il Governatore abbassò lo sguardo sull’orecchio mozzato. Era flaccido e pallido, un’isola di morte tra i volumi sul suo tavolo. Si chiese quale disegno degli Dei immortali si celasse dietro a tutto questo. Dietro alla sua sofferenza quadrata, alla malattia che svuotava la città. Ricordò il piccione nell’orto, ancora doveva arrivare la risposta dell’augure, ma forse gli accadimenti già la stavano precedendo…
Il colono Trofio continuava nel suo deprecabile svilimento delle procedure di legge berciando formule a caso con la sicumera che l’ignoranza concede a larga mano.
“Ecco la corruzione della nostra lingua e dei buoni costumi di pensiero che infine ci sommergeranno, che indurranno l’incurabile metamorfosi…” pensò il Governatore.
Trofio, asciugandosi le tempie imperlate, urlò - I maiali! Son tutti morti! Queste orecchie traggo a rappresentanza! -
E proseguì, inarrestabile come un torrente a primavera. Espose il luttuoso accadimento che aveva condotto alla perdita dei suoi maiali. Parlò della folgore scagliata nella notte sull’albero, dell’albero schiantato in due, una metà rovinata sul decumano e l’altra rimasta in piedi fino a che un colpo di vento la fece rovinare sulla porcilaia.
- I maiali sono tutti morti! - Ora il colono Trofio uggiolava con voce di cane e premeva tra le mani l’involto che andava macchiandosi di sangue.
Il Governatore socchiuse le palpebre.
Il dolore entrava furtivo con la luce, prendeva albergo dietro la fronte, roteava scomposto in mille frammenti ed infine si raccoglieva denso alle tempie, pronto a sfiatarne ed a ripercorrere l’intera via al nuovo raggio di sole.
Attese l’esaurirsi delle parole di Trofio poi si volse al secondo ospite - Parlate, liberto Velliano - e aggiunse - Con calma, se potete.
- Non ho colpe. Il colono Trofio dispone delle mie terre come affittuario, sua è stata la decisione di ricoverare i maiali sotto l’albero. L’ira degli Dei certo non rende conto agli uomini.-
A queste parole Trofio lasciò cadere l’involto. Nel toccar terra esso si svolse e ne rotolarono fuori altre orecchie mozzate, che si sparsero sul pavimento come fiori esangui.
- La mia famiglia andrà a morte certa! I miei figli patiranno i morsi della fame! Finirò davanti ai magazzini del porto a chiedere la questua. E’ questo il vostro disegno? Siete dunque un avvoltoio? - E ancora - Se dovrò darvi gli ultimi denari per l’affitto, voi, Velliano, sarete artefice della rovina di Trofio e della sua onesta famiglia!
- Ladro! - urlò Velliano - Bandito! La Cilicia è la tua casa! Bandito! No, sbaglio! Non sei un bandito, sei un mercante fenicio…. più scaltro di un Greco!
Il Governatore chiese silenzio, raccolse le forze per fronteggiare l’onda di dolore a martello sulla nuca, si massaggiò le palpebre. Figurò nella mente l’orto, la freschezza, la quiete, le ombre.
Dopo un lungo silenzio, rotto dallo sbuffare di Trofio e dall’ostinato grattare sul pavimento dei piedi di Velliano, parlò.
- Ebbene, vi concedo una remissione, colono Trofio. Una riduzione del canone pari alla terza parte per l’anno in corso. E per il prossimo. Questo a completa soddisfazione per il danno da voi patito. Che non abbiate altro a reclamare. –
Il volto di Velliano si fece rosso, le labbra carnose s’accesero di fuoco improvviso: - Trofio! Furfante! Ogni occasione è buona per estorcere! E il più delle volte a mio danno! Non occorre affaticare la memoria per ricordare che questo stesso inverno egli ha ottenuto il privilegio di lavorare senza canone un nuovo pezzo delle mie terre! Forse che io sono responsabile per i giorni in cui il gelo spezzava i sassi e frenava col ghiaccio la corsa delle acque?….I figli dei suoi figli diverranno padroni della terra che egli oggi bagna con il sudore! Essi guarderanno negli occhi i miei discendenti! Gli Dei non vogliano! Un colono! Un miserabile che divide cibo e letto con porci e cani! -
- Calmatevi, liberto Velliano! Così ho deciso, l’azione di legge è conclusa. –
Trofio s’illuminò di soddisfazione. Si profuse in ringraziamenti e scuse per l’intrusione in quel tranquillo mattino. Raccolse le orecchie mozzate e le offrì con grande dignità al Governatore.
- Vi ringrazio, colono Trofio, la vostra generosità è senza limiti. Ma conservatele per la vostra famiglia –
Trofio si congedò cerimonioso e sparì veloce.
Il Governatore invitò Velliano a restare ed a sedersi.
Velliano non trattenne oltre il proprio malanimo: - Ius civile! Ah! Esiste ancora? E’ mai esistito? Lo avete voi visto? Toccato con mano? E’ mai stato al vostro desco? Oppure avete visto un malfattore giudicato per le sue amicizie politiche, per la sua borsa gonfia ed infine congedato con un buffetto sulla guancia? –
- Amico mio…..è difficile sostenere il contrario….Ma siate ragionevole e lasciate i casi altrui…Questi non sono più i tempi in cui un’azione di legge vien persa perché si ricorre nel modo sbagliato. Ogni cosa è mutata, e gli uomini non si sottraggono a questo. Avete ragione su Trofio, ma avete torto nel pensare che io non agisca nell’interesse di tutti. Neppure voi volete che i coloni lascino le vostre terre, ne sortirebbe solo un male. Quando la terra senza uomini prevale sugli uomini senza terra, sappiamo che il declino è iniziato. L’equilibrio è risolto e, per lento che sia il moto verso la dissoluzione della società, nondimeno esso procede inarrestabile. Sapete che è così, liberto Velliano, molte volte abbiamo considerato su questo problema del nostro tempo. –
Velliano ruminava e torceva un lembo della tunica, in ostinato silenzio.
- Siete ricco Velliano. L’uomo più ricco dell’isola. Il vostro nome giunge fino a Roma, la vostra villa rivaleggia con quelle dei più potenti senatori, i vostri ospiti pranzano con lingue d’usignolo e fenicottero. Cos’è per voi un anno di canone? Ricordate che senza i coloni le viti starebbero oziose e voi non avreste la coppa piena. -
La testa di tartaruga di Eusebio spuntò dalla tenda. Il domestico protese il collo avvizzito, vide il sangue di porco sul pavimento e sul tavolo, strabuzzò gli occhi, trasalì e si ritrasse.
Dopo un istante irruppe nuovamente impugnando uno spazzolone, seguito dal giovane Pancrazio, sonnolento e pingue. Questi inondò il pavimento con una secchiata d’acqua poi sparse abbondante segatura. Guardò il tavolo lordato, esitò un istante e buttò segatura anche su di esso.
Eusebio prese a raschiare con lo spazzolone, producendo un pernicioso stridìo.
Il Governatore sollevò i piedi bagnati, spostò con rapido gesto carte e volumi, scosse la testa, elevò un pensiero agli Dei immortali che gli concessero il privilegio dei servigi del solerte Eusebio ed abbandonò il tablino allagato.
Velliano lo seguì, continuò fino all’uscio, prese congedo con malumore e s’allontanò nel bianco calore della strada.
Hora sexta
Al culminare del sole Eusebio annunciò l’arrivo di Flavio.
Il Governatore da giorni attendeva la visita del giovane, da tempo assente.
Nonostante la giornata pesante per il corpo e per la mente assediati dal dolore, lo avrebbe ricevuto con grande piacere.
Lo attese nella grande esedra al fondo della casa, inondata dalla luce meridiana.
In gioventù aveva molto amato la luce, gli ampi spazi, l’aria mossa dai venti.
Nei lontani giorni del suo arrivo nell’isola chiese perciò agli architetti incaricati della costruzione della casa di lasciare tre grandi aperture nel muro di fondo dell’esedra, in modo che l’ampia sala destinata a ricevere gli ospiti potesse ricevere la gran luce specchiata dal mare, il profumo delle ginestre, del rosmarino e dei mille altri fiori aggrappati alle rocce precipiti sottostanti. Azzia consigliò poi di spianare il terreno antistante l’esedra e di
lastricarlo fin sul ciglio del precipizio, ottenendo un terrazzo chiuso da un semplice parapetto di pietre chiare. Su quella spianata ella passava lunghe ore guardando la superficie marina, il lento approssimarsi delle vele, lo scorrere delle nubi sull’orizzonte, il pulsare livido della folgore, il mutare del turchese autunnale nel piombo e argento dell’inverno, il solcare del tempo sulla cresta canuta delle onde.
Lui oggi avrebbe preferito una più tradizionale esedra immersa nella penombra, un luogo meno aggredito dal chiarore, un luogo più adatto a mitigare il dolore, ad ammansirlo. Un luogo di luce incerta in cui confondere i bordi della sua ombra, del tenue trascolorare della sua vita.
In onore di Flavio aveva disposto che il pranzo venisse servito all’aperto, sulla spianata a ridosso dell’esedra. Con lento lavoro Eusebio e Pancrazio avevano predisposto ogni cosa: il tavolo imbandito con frutta e verdure, varie in colori e sapori secondo il gusto del Governatore e alcuni pesci, olive, noci e pani. Un grande telo bianco era stato infine teso ad ombreggiare dal sole violento.
In attesa dei commensali Pancrazio, impigrito e sonnolento, vigilava in piedi poco discoste dal tavolo.
D’improvviso, calato dalle profondità azzurre del cielo, un grande gabbiano prese terra tra il tavolo e l’immobile domestico.
Questi parve risvegliarsi dallo stordimento procuratogli dalla calura ma non ritenne necessario intervenire, forse confidando nella naturale diffidenza dell’uccello.
Il gabbiano esitò un istante, scrutò la pingue figura umana poi balzò sul tavolo con un disordinato sbatter d’ali.
Pancrazio, colto di sorpresa, emise un sonoro grugnito.
Nel medesimo istante, partorito dal buio rettangolo della porta, comparve Eusebio. Un’improvvisa smorfia di sdegno ne deformò i lineamenti. Il domestico si precipitò verso il tavolo, senza indugio brandì un randello, lo alzò e lo lasciò ricadere.
La mal diretta randellata distrusse il cesto con l’apio e le lattughe. Miglior sorte non ebbero pesche e prugne, scempiate da un secondo tentativo.
Il gabbiano balzellò illeso verso l’altro estremo del desco. Con fatica Eusebio tentò di allungarsi sul tavolo, traballò, agitò il randello in direzione dell’insolente bestia, poi si ritrasse a pianificare un nuovo attacco al profanatore.
L’anziano domestico aggirò il tavolo.
Il contributo di Pancrazio a tanti sforzi del vecchio non si spinse oltre uno svogliato dispensar consigli, principalmente inutili giacchè Eusebio sembrava assai pronto d’intento nel fronteggiare l’assalto, ma frenato nei gesti dalle membra logore, condizione purtroppo senza rimedio.
- Ecco….attenzione! Sfugge! Forse una frasca potrebbe intimorirlo…. -
Il pingue Pancrazio s’agitava e vociava ma null’altro.
Il gabbiano ristava immobile a testa alta e con occhio rilucente di sfida fisso all’assalitore. Poi, d’improvviso, calò rapaci colpi di becco a sconciare fichi, pani candidi, olive, ceci e datteri di mare. Il gesto di tanta aperta irriverenza suscitò l’ira di Pancrazio:
- Per Giove Statore! Ignobile predone! Il desco è rovinato! Dàlli col randello! –
Eusebio raccolse le forze e si gettò d’impeto sul tavolo. Incespicò nella veste, le gambe lo tradirono e si abbattè con fracasso. Nulla di quanto apparecchiato con tanta dovizia sopravvisse alla catastrofe. Quanto non ancora sconciato dall’uccello rovinò in parte a terra, il resto rovesciò sul tavolo, ormai sconvolto.
Il gabbiano, reso spavaldo dall’inaspettato favore degli ultimi eventi, si protese, spianò le ali e spalancò il becco accennando un attacco all’indirizzo del capo indifeso di Eusebio, prostrato sul tavolo e ormai abbandonato dalle forze. Vedendolo sopraffatto Pancrazio emise un grugnito feroce, e d’improvviso animatosi di eroica intraprendenza, scattò in avanti a braccia alzate.
Il gabbiano rapinò lesto una triglia, s’innalzò con fatica, roteò sopra la testa dei domestici arringandoli con voce stridula e manifestò infine il suo rancore con un aereo defecare.
Giunse il Governatore, girò lo sguardo sulla spianata e con un solo colpo d’occhio intuì l’accaduto. Considerò come la buona volontà e la dedizione del vecchio Eusebio ancora una volta avessero prodotto più danno che beneficio. Crollò il capo e ringraziò gli Dei immortali per avergli comunque concesso i preziosi servigi dell’anziano domestico. E del sonnolento Pancrazio, certo. Pancrazio, ispiratore di pace e tranquillità, mai fuor di misura nell’agire.
Pur l’azione non essendo la sua prima qualità….
L’ingresso di Flavio interruppe le sue riflessioni.
Nell’abbracciarlo avvertì il vigore del corpo del giovane, il palpitare della vita, non più nuova ma giunta all’acme della parabola. Stringere quelle membra dava ai suoi sensi l’impressione di una corrente rapida giunta d’improvviso a sconvolgere la morta superficie di un lago scuro e immoto.
Per un ingannevole istante quasi ritrovò la sensazione del vigore che in gioventù era stato tutt’uno con il suo essere. Un palpito vitale di cui non conservava altro che un esangue ricordo, ma che disegnava nella sua mente l’immagine dell’incedere regale di un uomo dalle spalle solide e ritte, una figura che lenta e sicura lo avvicinava, sfilava via e si allontanava da lui senza volgersi. Senza una voce, senza un gesto. E dissolveva infine in un tremolìo d’aria muto, in uno svaporare fatuo.
Consumarono il pranzo all’ombra, scegliendo con cura quanto la solerzia di Eusebio aveva scrupolosamente salvato dall’insulto del gabbiano.
D’un tratto la conversazione lieta di Flavio s’interruppe.
Il Governatore colse una luce rapida negli occhi del giovane, un gesto nervoso nelle sue mani, un tendersi della sua slanciata figura.
Avvertì un improvviso disagio.
- La mia nave è pronta. – disse Flavio. Le parole sgorgarono come il fiotto di una fonte costretta, gli occhi vagarono obliqui.
- Pronta? Come quelle di coloro che non sono tornati? –
Il Governatore spezzò una focaccia, la offrì a Flavio che riprese a parlare.
- Non è forse vero che la città sta morendo? Tutto qui è oblio, ogni giorno è memoria, Siamo sempre più lontani dalla vita, dal mondo. -
- Dici il vero. Le vedo Flavio. Vedo quelle isole di silenzio, di aria immota, di rovina e deserto che si allargano tra i decumani, che rodono la città. Ma quale la ragione? Forse le città sono come esseri vivi? Nascono, crescono, vivono ed invecchiano. E infine muoiono. Inutile cercare il motore del decadimento, esso è nella natura stessa del fenomeno, ne è parte inseparabile. Ma non è forse altrettanto vero che la città è il luogo dove si raccolgono le arti, le scienze? Il luogo dove l’uomo ha manifestato la parte migliore di sé, dove ha trovato stimolo e modo per far affiorare l’eccellenza dei prodotti della sua mente? Come posso accettare che questo finisca in mulinelli di sabbia ai bivii, in silenzi davanti alle fontane disseccate? Il silenzio, Flavio! Questo silenzio che tracima della quiete notturna, s’allunga a valicare il confine del giorno, lo invade, insidia l’operoso lavorio, lo circuisce e infine lo vince. -
Il Governatore chiuse gli occhi, fermò le sue parole, lasciò cadere le mani come piombi sul tavolo.
Flavio rimase silenzioso un istante, poi parlò a sua volta.
- L’oblio è nella natura delle cose. Difficile percepirlo quando logora qua e là, senza forza, senza intaccare, senza ammorbare. Ma v’è un momento in cui si fa audace, non trova difese sui bastioni. Allora mina la città fino a farla morire. Non diversamente un grande albero nel pieno del vigore fronteggia l’assalto dei mille parassiti mentre un altro già vecchio e malato soccombe. Questo penso. Non è in mio potere oppormi, ma posso
sottrarmi a questo futuro. Metterò il mare tra me e l’oblio, andrò verso la vita. La mia nave è armata anche per te, per Azzia e per i tuoi domestici. -
Il Governatore scosse il capo - Non è forse verità che il ricordo dell’uomo svanisce nell’unicità dell’essere, Flavio? Il solo modo per conservarlo è farne materia condivisa, depositata ed affidata a molteplici memorie. E dove questo accade meglio che nella città? Ecco, la città non è solo città di corpi, di commerci, di arti e pensieri. E’ città di memorie, è cumulo di ricordi deposti come pietre l’una sull’altra. Le memorie degli avi e le memorie dei vivi: senza che quelle ne stiano a costituire la base, queste non potrebbero elevarsi. Là dove dimenticato è il valore delle memorie, nullo è il valore del presente e non vi sarà faro per i giorni futuri.
Ma via gli uomini, via le memorie. Ben poca cosa è quanto affidiamo ai volumi ed alla pietra se raffrontato alla vastità multiforme delle memorie umane. Può forse un pugno di sabbia compiutamente parlarci dell’intera spiaggia? Del grande mare che l’ha generata e che la consuma? Ogni cittadino che volge altrove i propri passi è un grano di sabbia che scivola via, è un frammento di memoria che si allontana e si perde nella vastità dell’indifferente. Infine più saranno le caselle vuote che le piene, ai fatti mancheranno le cause. Noi stessi, i rimasti, avremo terrore nel volgerci indietro. Il passato sarà il nostro incubo e il futuro ci apparirà insensato. Il presente sarà oblio.
Flavio girò attorno al tavolo, alla ricerca di un nuovo sapore. Prese l’apio, lo spezzò e ne sfilò le nervature più resistenti che lasciò cadere a terra in un gomitolo capriccioso.
- Il destino delle parti è legato al destino del tutto: mentre qui gli acquedotti si interrano, a Roma se ne costruiscono di nuovi…-
- Quanto sei nel giusto, Flavio. – lo interruppe il Governatore. - Ma quanto eppure sbagli! Ce ne stiamo qui, dietro questi muri bianchi, reputandoci al sicuro dai pericoli. Le prue orgogliose delle nostre triremi fendono il mare e ci proteggono dalle scorrerie dei predoni, le legioni battono i confini più lontani e alla sola vista l’aquila d’argento incute timore. Pretende e ottiene rispetto, e dove le armi non agiscono convenientemente, i nostri denari comprano sicurezza, tranquillità e sottomissione.
Ma il nemico più pericoloso non è quello che sfrontato ci aggredisce in mezzo alla strada. E’ quello più subdolo e nascosto, che dorme nella tua casa, mangia il tuo stesso cibo. E noi che facciamo per ammansire il nostro più temuto nemico? Che fai tu, Flavio? Hai mai affrontato a viso aperto questo incubo ctonio? Hai mai levato anche un solo tuo pensiero per fronteggiarlo? -
Il Governatore prese un rametto di fico dal vassoio davanti a sé, ne staccò un frutto ruotandolo con gesto delicato e lento.
Nero, gonfio e vellutato. Una goccia zuccherina e trasparente stillò dal foro inferiore. Una goccia aspra, densa e bianca incappucciò il picciolo superiore.
Lo aprì.
Una vespa sorpresa a suggerne l’interno volò via rabbiosa. Un refolo di vento la trascinò lontano nel cielo azzurro. Il Governatore la seguì fin che potè con lo sguardo.
- Hai visto, Flavio? Questa è Roma, questo fico ricco e dolce, così turgido e promettente, dispensatore di meraviglie, custode di gemme rubine, pronto a dar gioia al palato di chiunque ne abbia desiderio….Ma dentro….nel suo ventre generoso e molle sta il divoratore. Occulto, silenzioso e prosciugatore. No, non dirò che vi sia qualcosa in qualche luogo che porterà alla fine del mondo, alla fine di Roma. Credo invece che in qualche recondito anfratto siano già germinate le malevole piante e che i loro semi maligni si stiano spargendo in ogni terra civile. Credo che i prodromi della causa che infine farà crollare i templi degli Dei immortali si stiano preparando, e noi non li riconosciamo come non riconosceremmo nel nostro stesso orto un’erba che mai abbiamo veduto prima. -
Flavio prese un secondo ramoscello dal vassoio, strappò deciso un fico, lo partì con abilità e precisione e lo mostrò al Governatore.
- Visto? Solo dolcezze e nessun divoratore qua dentro. – E lo mangiò. Poi riprese - Partirò con il cuore gonfio di dolore. Io non posso restare. E tu non dovresti. Ma attenderò ancora, confido che i prossimi giorni ti portino miglior consiglio….-
Con queste parole Flavio sembrò voler prendere commiato e si avviò verso l’esedra.
Il Governatore si volse verso l’orizzonte.
Una vela entrava nel porto.
Solitaria, lenta e bianca.
Hora decima
Che i giorni fossero ottusi coperchi di dolore o veloci barche di lievi pensieri, che l’esausto stancare della calura o il taglio feroce del gelo fossero compagni delle ore, uno era il costante momento che diluiva ogni consapevolezza del Governatore. Ed egli attendeva quel momento con la pace e la tranquillità con cui si attende ciò in cui si confida.
Attendeva l’istante in cui avrebbe levato gli occhi verso il cielo notturno e, seduto nell’orto, avrebbe rivisto le stelle tremolare nella fissità del silenzio.
Quel tremolare sentiva giungere a lui in forma di parole, benché d’un idioma straniero. Parole cui non sapeva attribuire alcun senso, ma che riteneva comunque a lui rivolte. E tanto bastava per sentire un refolo, un bisbiglio, un sospiro scendere accanto al cuore e lì prendere albergo per un istante.
E in quell’istante avvertiva la mente librarsi senza catene, scorrere vicina alla terra eppure lontano sopra di essa, fino a cogliere una differente forma di conoscenza, un ulteriore grado di comprensione.
Tanto era di meraviglia quell’attimo e tanto era transitorio, svanendo appena dopo averlo percepito.
Ma ancora mancava tempo a quel suo incondivisibile istante, a quel momento in cui avrebbe scorto dietro il limine umano una forma indistinta ed al tempo stesso l’avrebbe vista svaporare prima di riconoscerla. Una forma d’infinita molteplicità e d’inafferabile sostanza, lo strascico di un altrui pensante, celato nell’anima e portato alla superficie cosciente dall’estraneo richiamo del cielo stellato.
Il Governatore informò Azzia dell’invito del senatore Rubio Statilio e della prossima partenza di Flavio.
La moglie lo ascoltò in silenzio e immobile, un garbato biancore adagiato sul triclinare nell’esedra. La luminosità del suo sguardo sfuggiva all’ombra, il disordine argentato dei capelli sembrava in impaziente attesa del riposo notturno per sottrarsi al giogo di un nastro corallino.
- Questa è dunque la situazione? Tanto è cambiata questa nostra isola? – disse.
Il Governatore annuì – E’ così, Azzia. Un tempo questi moli erano coperti della folla rumorosa e composta dei mercanti. Non si contavano le merci scambiate, l’infinita varietà multiforme di cose ed animali. Queste cose ci portavano il vento del mondo terracqueo attorno a quest’isola, ce ne rendevano consapevoli, parte del tutto, parte di Roma, parte del mondo.
Non ricordo come sia avvenuto, quanto tempo sia passato nello scemare impercettibile della folla ai pontili, nel diradarsi dei volti stranieri, nel mutare del brusio indistinto delle innumeri voci in chiare ed isolate parole.
Non ho colto il moto del cambiamento. Mi è passato accanto e non l’ho visto, mi ha ingannato ancora la multiformità. Sempre più diverse erano le merci ed i volti: le barbe degli Assiri, i menti sfuggenti dei Nubiani, gli occhi scaltri dei Greci, le chiome selvagge dei Punici, le alte figure degli Etiopi. I convogli di grano hanno preso la via di piazze più
convenienti, e così le altre merci, merci che qui oggi non farebbero altro che ammuffire in empori deserti.
Deserti come i ginnasi, le fontane, i templi, le botteghe e le scuole.
L’apoteosi è sfilata via senza avvisare, non abbiamo compreso che iniziava il declino, e ora è tardi. E’ tardi, moglie mia. – Il Governatore accarezzò il volto di Azzia con un gesto leggero ed esitante, come se temesse di turbarne la tranquillità.
- Avremmo posto rimedio se avessimo saputo cogliere il mutamento? – chiese Azzia.
- No. Riconoscere il cambiamento non sarebbe bastato. Avrei pensato ad un temporaneo diradarsi del passaggio, al transitorio affievolirsi del commercio in questo porto in virtù di qualche vantaggioso proclama in un’altra piazza. Un mercante segue l’altro, le voci corrono più dei venti e quel che appare il meglio oggi non lo sarà più domani. E domani tuttavia il gioco si ripeterà e ancora tornerà lo splendore, ancora si caricheranno i marmi sulle navi per Ostia, per Capua, per Pozzuoli. Ancora si riempiranno le pàtere sotto i porticati e nelle locande. Questo avrei pensato. -
- E’ già accaduto. Poi la vita è tornata. Fu un sonno, un riposo. Ricordi? Allora accadrà anche questa volta. –
- E’ tardi, Azzia. Nessuno lo crede più. Chi può parte, segue la vita lontano da qui. Ed io non so convincerli a restare. Oggi rimanere significa perdere, essi non vedono un domani in cui confidare. Posso forse io dare loro questo domani? A che giovano le parole del governatore di una provincia senatoria? –
Lei lo guardò con intensità – Questa non è dunque più la nostra casa? Partiremo con Flavio e andremo a Roma? La nostra anima ci seguirà come uno schiavo in catene? –
Il Governatore si girò e si sedette sul triclinare, disegnò un cerchio nella cenere fredda del braciere.
- Grazie, moglie mia. Penserò al tuo desiderio ed al desiderio mio che tu vuoi condividere con me. -
Hora undecima
Il Governatore fece preparare da Eusebio un cesto con del miele, un pane, olive, fichi e un’ampolla di vino diluito. Con esso si avviò fuori delle mura, verso il tempio di Apollo Iperboreo. Là avrebbe trovato lo iatromante Cribrio.
Il sole scendeva dietro il promontorio, sbieche ombre rimpiattavano sotto i piedi del Governatore. Il dolore rimetteva infine l’assedio alla nuca, si prostrava in un esausto trasudare dalle tempie. L’ospite strascicava sì fuori dal corpo, ma l’avrebbe comunque percepito al suo fianco: presente, invitto, pronto a stringere ancora le dita di bronzo attorno al cranio.
Cribrio, malconcio, magro e sporco, giaceva semisdraiato a metà della scalinata che portava al tempio, accanto a lui una gallina osservava un punto nell’interstizio tra i gradini di pietra, all’apparenza studiando la valenza alimentare di invisibili corpuscoli.
Lo iatromante si spidocchiava svogliato e silenzioso.
- Salute a te, iatromante Cribrio – lo salutò il Governatore, posando a terra il cesto.
La gallina eresse il collo ed inclinò la testa per indagare l’invitante contenitore, accennò un passo ma fu trattenuta dal canapo che ne assicurava una zampa alla caviglia dello iatromante.
- Com’è la giornata, iatromante? –
- Sul finire –
- E l’orizzonte? –
- Limpido. – Cribrio si grattò pigramente il mento ricoperto di barba lurida. – Limpido –
- E gli accadimenti? –
Lo iatromante spostò il peso da un gomito all’altro restando semisdraiato. Prelevò qualche
foglia d’alloro dal cavo di uno zoccolo di bue accanto a sé, se le ficcò nella bocca guasta e prese a ruminare.
- Di poco conto. Di poco conto. –
Il Governatore si scostò di un passo per evitare la gallina che principiava a beccargli la tunica. Sul perché l’animale trovasse diletto nell’azione non riuscì a trovare alcuna spiegazione, forse qualche minuzia del pranzo era rimasta nelle pieghe del tessuto.
- La malattia è sulla città – disse infine – e da molto tempo ormai. Non pare esserci guarigione –
- La città si riempie. La città si svuota. – disse Cribrio ruminando. Dopo un lungo masticare riprese a parlare sputacchiando minuti coriandoli verdi – Come ogni recipiente. Essere ora vuoto ora pieno, questa è la sua natura –
- E se i futuri giorni portassero solo silenzio lungo i decumani e buio nelle case, ortiche negli orti? –
- Avverrà con certezza. –
Lo iatromante fu preso da un improvviso prurito. Si grattò il capo ispido, poi con insistenza il pube indi il ventre. Il moto sembrò risvegliare l’interesse della gallina che si avvicinò scrutando la cenciosa veste di Cribrio. L’indagine si risolse con una fulminea beccata ed uno scuotimento di cresta.
- Considera due grandi pietre – disse lo iatromante – L’una rozza e appena strappata alla terra, l’altra lavorata dallo scalpello in forma squadrata. E su questa immagina poi il più raffinato rilievo del più abile scultore. Molto diverse le vedono i tuoi occhi, ma della stessa materia è la loro essenza. Solo l’esser pietra ha consentito allo scalpello l’opera, ma la stessa pietra verrà infine lisciata dalla pioggia e l’opera verrà così cancellata. La pietra non può che tornare ad esser pietra. –
Cribrio soffermò lo sguardo su un punto lontano e aggiunse - Il tempo…… Il tempo - e tacque.
- Dunque nulla suggeriscono gli Dei? –
Lo iatromante stirò il collo. Stese verso il cesto una gamba macchiata di sporcizia rappresa e ne smosse il contenuto con le dita del piede, gettando al contempo un’occhiata furtiva. Riprese a grattarsi.
- Nulla – disse poi.
Cribrio ammutolì, l’immobilità scese nel suo corpo, gli occhi rimasero fissi ad un punto dell’orizzonte.
Il ruminare si fece dapprima lento poi cessò.
Il Governatore comprese che il colloquio era giunto al termine: lo spirito dello iatromante era fuggito dal suo corpo, lasciandolo vuoto ed ancor più inutile. Già stava levitando su luoghi sconosciuti, lontano dalla vita degli uomini, vicino alle dimore degli Dei.
Forse in ascolto delle loro parole.
A lui erano rivelati i beni ed i mali dei giorni futuri.
La sua anima era stata rapita dal fiato divino, sospinta su rotte sconosciute. Solo al ritirarsi del soffio degli dei avrebbe fatto ritorno nel suo fragile involucro, recando nuove ed inaudite conoscenze, apprese porgendo l’orecchio alla sapienza superna.
Il Governatore si congedò da Cribrio e riprese la strada verso casa, ripromettendosi di tornare il giorno dopo o quello ancora successivo. Forse lo iatromante dal vagare della sua anima avrebbe riportato un consiglio, qualche utile rimedio per la malattia stesa sulla città.
Ma era bene non confidare in troppo larga misura.
“Non a tutto v’è rimedio. Non a tutto. Benchè ogni cosa possano gli Dei, i problemi degli uomini restano problemi degli uomini. Non ad ogni accadimento è possibile opporre resistenza con buon risultato.” Questo Cribrio più volte lo aveva detto con grande convincimento ed il Governatore ne faceva frequente esperienza col suo stesso corpo.
E massimamente arduo, considerò il Governatore, si presentava trovare un rimedio per quei
mali che sottili, silenti ed impalpabili si facevano nel tempo più solidi, più approfondivano le radici. Fino a divenire essi stessi la vera sostanza ed il corpo un miserabile involucro, un vaso senza più alcun significato se non quello di albergo del male.
Così era per il suo corpo.
Così era per la città.
Come per ogni altro fenomeno anche la malattia descriveva un cammino.
Un cammino con un principio, un dipanarsi ora rapido ora lento, ed infine una conclusione. Se ora stendeva il suo manto sulla città doveva pur esser principiata in qualche modo, v’era stato un limine tra il tempo dei giorni luminosi e quello dell’oblio. E in quell’incerto confine doveva situarsi la cagione, non altro che quello doveva essere il nascondiglio del subdolo nemico. Là andava cercato: nell’interrarsi degli acquedotti, nell’esuberare delle erbe tra le lastre dei decumani, nell’ultimo commensale delle taverne, tra i blocchi rosa di granito giacenti sulle banchine deserte del porto.
Ma quale degli organi aveva per primo smesso di funzionare? Dove si situava il non riconosciuto inizio? Quale vacuolo aveva per primo ospitato la malevola flemma? Quale mercante aveva per primo volto altrove la prua della nave? Quale bottega aveva cessato per prima? Come era iniziata, da quale direzione era provenuta la malattia?
O forse da lungo tempo il velenoso umore circolava per il corpo affliggendone i più oscuri angoli dei più distanti quartieri?
Zefiro si alzò improvviso, smosse i cespugli lungo la via, le erbe tra il lastricato della strada, solleticò i peli sulle braccia del Governatore, portò il profumo della verbena e dell’origano alle sue narici. I sensi lo allontanarono bruscamente dai pensieri.
Hora duodecima
Era tempo di rispondere alla gradita lettera di Rubio. Il Governatore si ritirò nel tablino, dove Eusebio aveva già acceso una lucerna. Prese lo stilo e affidò alla lettera quanto aveva in animo.
Il Governatore della Provincia Senatoria al senatore Rubio Statilio nella sua villa al colle Jano.
Il tuo nobilissimo invito altro non fa che aumentare l’affetto che nutro per te, amico mio, e riempie il mio cuore di commozione.
Misterioso è lo scorrere della vita umana, Rubio. Siamo superiori agli animali, abbiamo un intelletto potente che ci guida, da loro ci distinguiamo perché siamo consapevoli del gioco del Fato, pur senza sottrarcene. Ma nonostante questo, siamo stupidi e orbi di fronte a taluni accadimenti: a quei fenomeni che lenti si dipanano.
Ecco, sì. Nel vedere una città che muore, un lago che dissecca, un figlio che cresce… in questo abbiamo occhi di pollo. E siamo dunque come gli animali di fronte alle stagioni, al dì ed alla notte: avvertiamo il risultato del cambiamento ma non il cambiamento. E non vedere altro che il risultato non è forse solo guardare al piede della somma? Avere contezza dei fenomeni quando ormai essi sono compiuti? Quando ormai il tempo dell’azione ci è sfuggito?
Qui le cose sono mutate, amico mio. Tutti lo vediamo, tutti lo sappiamo.
Anche lo schiavo più umile e ignorante vede con i propri occhi gli orti lasciati al rovo ed alle ortiche. Quanto ai mercanti, al sangue che vivifica questo immenso corpo, essi per primi hanno presentito il cambiamento, forse quando ancora esso andava solo approssimandosi. Forse l’istinto ha reso visibile ai loro occhi ciò che ancora non poteva essere percepito ma che pure era presente in qualche forma, sperso nelle ore deserte, nei giorni immutati, come un pesce confuso tra milioni nel banco.
Io sono cambiato, questo mio corpo è cambiato con la città, e lo specolo mi scruta ogni mattina con gli occhi cadenti di un vecchio. Fatico a discernere quale sia la direzione a cui tendono gli accadimenti, non so capire il domani e non riesco a lacerare questa nebbia.
Perciò non lascerò quest’isola e la mia casa.
Ho governato questa città in giorni luminosi, ne ho percorso le vie con passo giovane, rapido e sicuro. Ho cercato di sanare le ingiustizie, di spronare i commerci, di apparecchiare al mondo questa terra quale degna rappresentante della grandezza di Roma. Ma un nemico troppo astuto e mutevole mi si è opposto.
Come l’occhio del pettirosso considera immota la serpe cacciatrice mentre essa s’avvicina, io non ho veduto i segni del decadimento fino a che esso non ha affondato le radici. Abbattere questo nemico è ora superiore alle forze che mi sono rimaste.
Qui la fiaccola di Demetra ha cessato di ardere: è spenta e fredda.
Tuttavia non posso lasciare questi luoghi, questa è la casa della mia anima.
E l’anima non cambia indirizzo, amico mio.
Ma ho abusato del tuo tempo, nobile Rubio.
Ti lascio alle molteplici occupazioni ed agli affari di Stato che empiono le tue giornate.
I miei domestici anche quest’oggi mi gratificheranno di una buona cena (meglio se composta e contenuta), Azzia condividerà con me la dolcezza della sera e l’orto mi concederà un poco della sua quiete.
Ed io con piacere lascerò il mio occhio vagare per questo cielo stellato.
Sto bene se tu stai bene.”
********************************************************************************************
Ritengo sia stato l’avvicendarsi di sole e veli di pioggia a tener lontani i visitatori da Tharros quel giorno che ne visitai le rovine. Vagare tra resti di magazzini, colonne decapitate e brandelli di lastricati protesi al mare fu uno sfiorare tempi lontani e popolarli di voci antiche.
Tra la confusa ridda mi s’affiancò il Governatore.
Mi presi licenza d’andar oltre la sua richiesta, che in verità fu una sola: non cedere all’oblio.




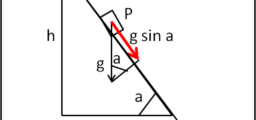


2 commenti
Grazie del commento Daniela. In effetti il mio modo di raccontare chiede al lettore di non aver fretta. Come quando si va a camminare per il solo piacere di farlo.