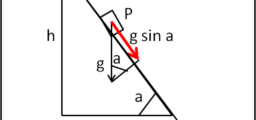Categorie: Arte e letteratura
Tags: bicicletta Ciclismo I tesori di Guido Racconti
Scritto da: Guido Ghezzi
Commenti:0
IL GRANDE SOLITARIO
Questo è uno dei "Tesori di Guido" raccolti nella sezione d'archivio ad essi dedicata
Le ruote della bicicletta non portano in viaggio solo un uomo ma anche una filosofia di vita.
Chi ha conosciuto il Grande Solitario sa che questo era il suo pensiero.
Il Grande Solitario
(di Guido Ghezzi)
Grande Solitario. Così lo si appellava tra noi fanatici velocipedisti.
 Grande poiché lo era davvero la sua figura: un corpo di due metri e più, secco secco con certe ginocchia nodose e all’apparenza così rigide da sentir male alle proprie al solo guardarle; due mani enormi, inerti, appese alle braccia come badili al chiodo; i piedi ampi come chiatte e poi un testino acuto lassù in cima, forato da due occhi bovini, spenti e fissi. Quell’altezza troposferica l’aveva tantalizzato fin da ragazzo, affermava nelle rare occasioni in cui s’apriva a dir di sè, quando giocava svettante sui birbanti coetanei che a stento gli arrivavano al torace, facendolo sembrare un essere d’altra specie (giacchè un adulto non lo pareva proprio, imberbe e acerbo com’era in tutta evidenza) ovvero un apprendista trampoliere, malfermo e traballante. I medesimi miracolosi poteri che lo rendevano inestimabile per recuperare una palla artigliata ai rami d’un albero si tramutavano in una condanna nella maggior parte dei giochi: impossibile era per lui partecipare alle spedizioni in misteriosi antri e cantucci, distendersi in una corsa era solo un risvegliare dolori articolari e i suoi maldestri tentativi di affidarsi a qualunque nascondiglio eran salutati da risa e sberleffi all’inevitabile sporgere del deretano o di un piede o gomito che fosse.
Grande poiché lo era davvero la sua figura: un corpo di due metri e più, secco secco con certe ginocchia nodose e all’apparenza così rigide da sentir male alle proprie al solo guardarle; due mani enormi, inerti, appese alle braccia come badili al chiodo; i piedi ampi come chiatte e poi un testino acuto lassù in cima, forato da due occhi bovini, spenti e fissi. Quell’altezza troposferica l’aveva tantalizzato fin da ragazzo, affermava nelle rare occasioni in cui s’apriva a dir di sè, quando giocava svettante sui birbanti coetanei che a stento gli arrivavano al torace, facendolo sembrare un essere d’altra specie (giacchè un adulto non lo pareva proprio, imberbe e acerbo com’era in tutta evidenza) ovvero un apprendista trampoliere, malfermo e traballante. I medesimi miracolosi poteri che lo rendevano inestimabile per recuperare una palla artigliata ai rami d’un albero si tramutavano in una condanna nella maggior parte dei giochi: impossibile era per lui partecipare alle spedizioni in misteriosi antri e cantucci, distendersi in una corsa era solo un risvegliare dolori articolari e i suoi maldestri tentativi di affidarsi a qualunque nascondiglio eran salutati da risa e sberleffi all’inevitabile sporgere del deretano o di un piede o gomito che fosse.
Gli anni scolastici erano stati una pugnace costrizione in sedie e banchi sottomisura. La lunga frizione sui legni dello schienale, conseguente al suo agitarsi per trovar conforto in quelle ore di supplizio, gli aveva piagato la pelle del dorso, disegnando per ogni vertebra una cicatrice che in età matura assommava a quel ricordo lontano un saltuario prurito.
A muovere un simile corpo mai aveva imparato, si diceva tra noi per celiarlo. Forse si trattava di impresa superiore alle sue risorse ma, riconoscevamo anche, nessuno di noi poteva invero sapere quanto impegno chiedesse dar moto a simili leve senza ottener gesti che non paressero quelli d’un arcaico automa.
L’avanzare dell’età l’aveva punito ancora, gratificandolo di flogosi, calcificazioni e vari altri nocumenti, fastidiosi come suzioni di tafano. Talora lo si vedeva giungere di primo mattino in impeccabile tenuta: scarpette, calzoncini con fondello, maglietta a tasche dorsali, guantini e quel suo caschetto di cuoio russo, invecchiato almeno quanto lui, che si ostinava a portare ad onta dei più filanti caschi moderni. Incedeva lento con la bicicletta accompagnata al braccio come una dama ad un ballo, una bici dalle meccaniche obsolete ma linda e curata fin nella più riposta coppiglia. Sosteneva, pur non avendola mai esternata, che una storia lunga e gloriosa aveva quel mezzo.
Di primo mattino, si diceva appunto, compariva con quella sua calma impenetrabile e ci salutava uno ad uno con misurata cortesia.
- Come stai? – era la domanda che spesso gli veniva rivolta, producendo un convinto “Bene!” in risposta, cui seguiva però un regesto di doloretti, fittarelle, enigmatiche affezioni e vaghi fastidi che elencava con l’aggiunta di cenni incerti ad indicare un gomito o il malleolo o il costato o, ancora e più spesso, la regione cervicale. Infine ribadiva un “Ma tutto bene!” come a rassicurarci che lui ci sarebbe stato, alla sgambata avrebbe preso parte anche quel mattino.
L’accessorio che completava l’appellativo del Grande era invece un’invenzione mutuata non dal suo corpo ma dai suoi atteggiamenti una volta in sella: amava pedalare in solitudine.
Non propriamente solo, per la verità. Si partiva infatti in gruppo tra lazzi e commenti di reciproco scherno, ci s’avviava per rettifili alberati e curvoni in diligente fila (per scongiurare fatali confronti con automobilisti nervosi) e si sboccava finalmente in campagna, a dar sfogo ai garretti impazienti. Ma lui, il Grande Solitario, appena poteva si sfilava, lasciava un centinaio di metri, duecento al più, dal postremo dello smanioso manipolo e proseguiva sempre tenendosi a distanza, né cedendo né guadagnando terreno; così, a bella posta, per gusto suo. Prendeva la strada tranquillo e muto, con quel suo ritmo di pedale monotono, né lesto né moscio, ipnotico e cadenzato. E noi lo si sapeva bene: lui era sempre là dietro e là sarebbe rimasto fin al termine del giro. Ci seguiva vigile e attento, solo all’apparenza estraniato; non occorreva darsi pena di verificarne l’effettiva presenza, ormai era condivisa e consolidata certezza che non si sarebbe staccato nè sperso per altra via.
In sella la sua taglia eccezionale risaltava ancora più evidente: un giunco flesso fin quasi a saltare in pezzi nell’adattarsi ad un telaio che, lo si aveva avvertito più volte, ma vanamente, era di misura insufficiente. Nonostante ciò di abbandonare quella bicicletta in favore di un mezzo più confacente non era ipotesi da considerare, aveva stabilito fermo. Forse gli anni di ordalie patite a scuola l’avevan a tal punto assuefatto alla scomodità che ormai l’agio posturale era svanito dal campionario della sua stessa percezione corporea e il Grande Solitario sosteneva senza apparente fastidio ore e ore di quel tristo rattrappirsi sulla bicicletta.
Vederli transitare, mezzo e conducente, induceva all’animo un che di patimento: parevano due meccanismi mal adatti l’uno all’altro e forzati in un unico marchingegno da ostinazione bambinesca. Un mescolio di rote, levismi, arti, pedivelle, gomiti, rocchetti e caviglie che dava l’impressione d’esser ad un soffio dall’ingripparsi, sopraffatto da invincibili attriti. Attriti superati invece con immane sforzo per poi scivolar via in un liscio orbitar di pedale. Il liberatorio roteare durava un attimo e poi di nuovo il marchingegno incappava nell’incessante tortura che subito vinceva e poi ancora vi ricadeva e così via. A nessuno riuscì mai di capire quanta fatica gli costasse tener dietro a noi, vanitosi figurini alla moda su fiammanti telai, leggeri come piume e portati nel vento da meccaniche prodigiose. Impassibile era il suo volto, senza luce i suoi occhi, immune dall’affanno il suo respiro, come fosse una marionetta guidata da un burattinaio svogliato e lontano dalle quinte del mondo.
Epperò lo si riteneva insostituibile veterano del nostro plotone e quando occorreva il caso che mancasse al ritrovo mattutino si partiva con un peso, una sorta di riserva, come andassimo via consci d’aver abbandonato un compagno e non si chetava davvero fin quando non ricompariva il suo caschetto di cuoio russo e la sua bici.
Il Grande Solitario osservava certi suoi speciali riti che ormai avevan fatto di noi dei fervidi adepti.
Talvolta, tra una salita e l’altra, ci si concedeva un breve ristoro presso uno dei tanti surgimenti d’acqua, sparsi per le valli e a noi ben noti.
- Quest’acqua è sacra! – diceva con beatitudine dopo la prima sorsata.
- E il nostro è un sacri-facere! – rispondevamo ad una voce e tra le risate, per canzonarlo con quello storpio linguaggio. Tal protocollo s’era consolidato dopo che, molto tempo addietro, egli ci aveva fatto notare come ritenesse il nostro un “sacrificio” perché l’antica radice del lemma indicava il “render sacro” e tale qualità appunto lui riteneva appartenere a quelle fatiche a zonzo in sella. Fatiche non rivelate, al pari di certe religioni, motivate da attrazioni senza volto né fine terreno.
Vagando su tratte che sceglievamo tra le meno percorse da automobili e torpedoni, occorreva che lo svalicare per l’acume di un colle presentasse allo sguardo un vecchio casolare. Vedevamo allora il Solitario rallentare, valutare vista e declivi, campi abbandonati e filari di confine; poi riprendeva velocità, ci raggiungeva e, annuendo convintamente, c’informava che presto o tardi avrebbe lasciato la città per una campagna come quella. Chissà, forse proprio quella. E avrebbe drizzato i pali della vigna, rinvigorito il campo, risistemato i coppi del tetto e scacciato i ghiri dal solaio, unici sfaccendati abitanti rimasti nel rudere.
Esaurita la stringata informativa tornava nella sua solitudine lasciandoci sfilare avanti.
Tutti ricordiamo la stupefazione al primo presentarsi del Grande e del suo vetusto armamentario, ma di sorprese ce ne avrebbe regalate altre.
Il profondo dell’estate non era il tempo migliore: il caldo ci sfiancava, il sole scottava cervice, braccia e gambe e si terminavano le sortite in uno stato di leggero rimbambimento, riarsi più dei campi e bramosi solo d’un bagno fresco. Primavera ed autunno ci esponevano a tantalizzanti piogge e temporali, la vernata al gelo ed al vento. Preso atto, come ogni ciclista, che non vi era una stagione ideale per pedalare e che pertanto si doveva essere risoluti a prendere quel che arrivava senza lagnarsene, era ben raro che si rinunciasse alla fuga sulle nostre due ruote. In quelle occasioni era bandito perder tempo: si partiva, si macinavano chilometri e chilometri senza sosta, fino a drenare le ultime energie dai nostri corpi ed a rendere i posteriori come focacce.
Ci si trovò un giorno a percorrere uno stradello costellato di fresche fatte di vacca. Si dovette procedere a bisciabova per evitarle e già a quella prima risibile difficoltà lo vedemmo, il Grande Solitario, condurre la bici in un serpeggiare nervoso, poi esitare, rallentare come se l’aria l’invischiasse sempre più ed infine metter il piede a terra.
Ci fermammo. Una foratura? Beghe meccaniche? Un improvviso malanno (nel caso suo possibilità sempre da mettersi in conto)?
Alle nostre interrogazioni tacque, spiegò il braccio destro in direzione del culmine della strada e rimase muto in quella posa, come una gru svettante in un cantiere.
Ma in quella direzione non v’era nulla di rimarchevole ai nostri occhi, a parte i corpi biondastri produttori delle lordure testè evitate: una ventina tra bovi, vacche, giovenche e vitelli, pigri a bordo strada.
- Le vacche – disse infine fissando i ruminanti.
Ci guardammo l’un l’altro, stupefatti.
Il Grande Solitario aggiunse poi che non poteva procedere oltre. Le vacche l’avevan visto e quindi, spiegò irremovibile, non v’era altra risoluzione che girar la bici e tentare altre direzioni, possibilmente fuori della vista della mandria. Sulle prime si pensò ad una burla e s’iniziò a ridacchiare ma lui girò la bici e lesto prese la via del ritorno. Interdetti lo vedemmo scivolar via, giunto alla prima curva si voltò, accennò un commiato
e sparì.
Giorni dopo, al suo primo riapparire, lo incalzammo, rosi da una curiosità scimmiesca che soddisfece di malavoglia.
Le vacche lo impaurivano. Al punto da non poterne tollerare lo sguardo, per non parlare del repentino scuotimento del testone cornuto, moto che lo gettava nel profondo terrore pur sapendo che all’origine v’era l’innocuo tentativo della bestia di liberarsi da mosche e ronzoni. Qualcuno notò che mai, in vita sua, aveva saputo di aggressioni da parte di mucche, anzi tenute da sempre per simboli di tranquillità e pace.
Ma il Grande Solitario disse che, se non una spiegazione vera e propria, l’origine di quel suo turbamento c’era, riposta negli anni di gioventù.
In una disgraziata giornata di inizio primavera se ne stava, come sempre, ultimo della fila dei compagni di classe davanti all’ingresso della scuola in attesa d’entrare. Il paese era affogato nella campagna e file di bovini lasciavano in quei giorni le stalle per tornarsene a pascolare finalmente all’aria e in mezzo all’erba. Sarà stata quella brezza che entrava inebriante nelle froge o l’ansia di gustar fili d’erba nuovi nuovi o qualche fragranza di rinascita nel venticello, o chissà che altro, insomma le bestie fremevano impazienti. Una di loro, una giovenca, incapace di trattenere quel singulto di gioia, fece un balzo, scansò la fila di compagne e prese una corsa a rotta di collo per il prato, muggendo e scuotendo il cranio. Il bovino puntò la truppa di scolari, che forse neppure vedeva, ebbro com’era. I ragazzetti urlarono e fuggirono mentre lui, il Grande, perso in nuvoli di pensieri impigliati lassù, nelle altezze aeree del suo testino, non s’avvide della minaccia finchè non fu troppo tardi. La mucca gli fu addosso, lui rimase piantato lì come un legno secolare, trasformato in un monolito di terrore e vide l’occhio, quell’occhio abissale ed inespressivo, quello specchio di vuoto infinito e fisso.
Un attimo ancora e tutto sarebbe finito se non fosse riuscito il guardavacche ad assestare un’estrema randellata sulle terga del fessipede che scartò e finì la sua corsa in mezzo alla piazza, sbruffando vapori di libertà nell’aria tersa.
Ma quell’occhio, quell’occhio di inchiostro lucente, s’era inabissato nell’animo del Grande, scavando un ipogeo di terrore. Affondato in quel pozzo di buio, raccontava con brivido, aveva visto un puntolino. Una facella era sfavillata per un istante, una stella persa nell’infinito atramento, un brillìo minuscolo di intelligenza, rannicchiata nell’immensa notte della bestialità primordiale. Quel subitaneo contatto con la mente bovina fu una malìa, una fattura a vita.
Il Grande non si riprese più dallo spavento; per somma crudeltà fu a lungo stuzzicato dai compagni di scuola che volevano raccontasse la sua infinita paura. Ma la pretesa era irricevibile, troppo alto il costo, mai avrebbe accettato il supplizio di rivivere l’aborrito istante.
Ognuno vive perseguitato dai propri incubi del resto, e il terrore ispirato dalla visione d’una vacca, in fin dei conti, non va considerato neppure tra i peggiori, anzi si potrebbe osservare che tenga persino una sua sfumatura di originalità, un sentore d’arcaico, di rupestre deferenza.
Quel gigantesco compagno era per noi una speciale presenza, già lo si è detto, una presenza che nobilitava tutto il drappello. Perché tutti noi, da noiosi impiegati in grigi lavorii tra immobili realtà, appena montati in sella si subiva un’impreveduta metamorfosi: all’istante gli anni cadevano a terra come bluse d’impaccio, s’accendevano le pupille smorte e dei grevi pensieri si vuotavan le tasche. Fin dai primi colpi di pedale ci si aizzava l’un l’altro ed era tutto un intrecciarsi di incitamenti:
- Forza, forza! –
- Dai! –
- Non mollare! –
- Vum vum vum! - e via, invasati, a mettere quanto più asfalto possibile sotto le ruote.
La smania ci prendeva tutti come l’avessimo inalata con i fumi di qualche pozione e ne fossimo rimasti schiavi senza averne contezza. E si straparlava, intanto, di nuovi telai, migliori meccaniche, tubolari invulnerabili e stupefacenti prestazioni, rigorosamente condotte in assenza di testimoni.
A quella pozione il Grande Solitario era immune.
Pedalava al di sopra di ogni nostra fregola, fisso a qualcosa oltre l’orizzonte che leggeva come suo unico traguardo. In lui non un accenno di trasporto, non un moto di sfida, non una parola di troppo. Pedalava in uno spazio ed in un tempo solo suoi, che trascinava con sé come fossero vincolati alla sua bicicletta; noi, infiammati, si gareggiava d’impeto, apprendisti incapaci di quel suo distacco olimpico, negligenti e ad un tempo proni di fronte a tanta elevazione di spirito.
Una sola cosa, a parte le vacche, pareva sottrarlo al suo distacco e trascinarlo in un vortice di crudo fastidio: un collega di pedale, uno di quelli che tutti avremmo senza esito pagato purché si dedicasse ad altro.
Costui rispondeva al nome di Preteso Picozzi.
Non era delle vicinanze, per nostra fortuna, sicchè le uniche occasioni d’incontro capitavano quando egli disgraziatamente s’iscriveva ad una delle sfide amatoriali organizzate nel circondario. La sola presenza del nome nella lista dei partecipanti era motivo di improvvise diserzioni, malori dell’ultimo minuto e sopravvenuti impedimenti, invocati da coloro che per nessun motivo avrebbero tollerato di condividere la giornata con lo scomodo personaggio.
La presenza del Picozzi si manifestava prima di riconoscerne la figura nella moltitudine per via di quella sua voce sforzata oltre il tollerabile, una voce da gracula isterica con cui infliggeva sarcasmi e acide notazioni agli sventurati colleghi di sella che incrociava. Nel magma già ribollente dei preparativi al via spandeva agitazione, dardeggiava lazzi e maneschi scherni, condiva il tutto con sgarbati gesti e rideva poi sguaiatamente di quei suoi esordi mentre pungeva l’intorno con pupille di ossidiana.
Per una qualche strana combinazione il Picozzi s’esaltava nelle situazioni di peggior frangente. L’improvviso levarsi di venti potenti, una grandinata, un torrenziale piovasco, una caduta corale; un qualunque evento che imponesse disagio o tensione nei compagni di gara lo eccitava bestialmente. Forze ultraterrene sembravano in quella prender possesso dei suoi nervi e tenderlo in posture animalesche: protraeva il collo, lo sguardo s’iniettava di metallica fissità, s’irrigidivano le mascelle in un ghigno feroce, ingobbiva come un ocelotto pronto al balzo, s’innalzava sui pedali, infiammato del vigore che agli altri veniva meno e infine, incapace di contenere l’immane tensione montatagli dai visceri, eruttava in furiose risatacce e urlava a tutta gola – Sangue! Sangue! E’ l’ora del sangue! – alludendo alla sofferenza abbattutasi sui partecipanti. Si dava poi a pungolare questo o quello che all’occasione si trovasse affianco irridendolo con ringhiose imitazioni: se quegli sbuffava per lo sforzo il Picozzi s’atteggiava a vaporiera, se invece tremava per i chicchi gelati giù per il collo allora scuoteva tutto il corpo e crepitava i denti, a chi era vittima di improvvisi lassi di forze mimava un afflosciarsi sul manubrio e così via. Farciva il dileggio con funamboliche rime inventate al momento, per lo più oscene. Nessuno scampava.
Naturalmente Picozzi non era immune agli inconvenienti ed alle seccature ben note ai ciclisti: forature, salti di catena e incidenti meccanici capitavano anche a lui. In quelle occasioni lo si vedeva a bordo strada mentre, predato dall’ira, rivolgeva insulti e insolenze all’aria, gesticolava e ragliava a denti stretti. A chi sfilava via, magari incurvando un giusto sorrisetto, neppure badava. Insomma per il Picozzi l’appuntamento agonistico constava solo nell’infierire su qualcuno, a prescindere dal suo personale risultato di classifica. Era l’istante particolare che lo motivava: più gli eventi gli davan il destro di sfogare la sua arroganza più s’ingigantiva il suo godimento e più studiava modi per farsi beffe del malcapitato bersaglio.
Come s’è detto l’eccezionale quota del Grande Solitario imponeva la sua presenza al contesto del caso, ad onta del suo opposto desiderio di non risvegliare alcuna attenzione. Particolarmente il fastidio cresceva insopportabile quando era il Picozzi a farsi sotto, apostrofandolo da lontano con un rozzo “Eilà perticone!” cui seguiva un suo rapido approssimarsi nella calca a forza di gomitate e spintoni. Il Grande Solitario abbozzava un improbabile tentativo di mimesi tra i colleghi di pedale ma veniva tosto raggiunto e subito fatto bersaglio dal Picozzi. Manate, pacche e scuotimenti travolgevano il nostro compagno e lui, incapace di allontanare l’importuno per carenza di spirito e non certo per insufficienti mezzi fisici (un solo spintone di quelle smisurate braccia avrebbe sedato all’istante l’importuno), subiva muto ed immobile. Picozzi passava poi a maltrattare la venerata bicicletta. Smuoveva leve e pizzicava cavetti, torceva il manubrio e grattava la sella sotto gli occhi del Grande, fissi d’orrore e sofferenza nell’assistere alla feroce profanazione. L’empio dissacratore non risparmiava aciduli commenti: - Ma funziona ‘sta roba qua? Ne sei certo te? Non è che ti s’apre in due? - Infine, sfogato il demone, il turpe sacrilego prendeva il largo, lasciandosi dietro una cantilena di sollazzo.
Dunque, per quanto apparisse inverosimile, un tratto accomunava i due: entrambi affrontavano il certame scevri da ogni turbamento agonistico, benchè sulla scorta di motivazioni che più differenti non potevano essere. Da tal coincidenza di opposti non poteva che darsi una sulfurea risultante se per ventura i due venivano a tiro di pedale.
Un sacro fuoco accendeva allora il Grande, ne scioglieva l’olimpica indifferenza e lo scagliava sul nastro asfaltato con l’occhio torto a cogliere la reazione del Picozzi. Questi rispondeva del pari e principiava un duello che durava fino al traguardo, che spesso li vedeva esausti protagonisti di scomposte volate finali, quasi sempre risolte per un’incollatura.
Episodi questi che facevano da soli la storia del cimento, stante la gran notorietà dei due individui.
Fu in una di tali occasioni che il fato volle tracciare uno dei solchi con cui ricorda agli uomini che ogni vita è una storia scritta dall’intrecciarsi con altre mille storie, esse stesse scritte dall’intreccio con quell’una per risultare in un guazzabuglio di cause che divengono effetto ed effetti che si fanno concause; un guazzabuglio senza capo né coda, irto di biforcazioni e quadrivi. Un intrico ove, forse, ciascuno riconosce un proprio
disegno nell’estrarlo dall’insieme, disegno che tuttavia, se visto da un po’ più lontano, svanirebbe per lasciar campo a uno scarabocchio fanciullesco, tracciato al non saper che fare d’un eccesso di tempo.
L’identità del testimone oculare non fu mai assodata, un velo di incertezza annebbia pertanto taluni dettagli dei fatti, ma la sostanza ultima, visti gli esiti manifesti agli occhi dei presenti, è certa.
I due, dunque, già da chilometri si dannavano, presi in una lotta dal verdetto incerto. Il Grande svalicò al sommo dell’ultimo colle ma incalzato dappresso dal Picozzi che s’avventò sui tornanti in discesa, avvinghiato al manubrio e frullando i pedali. Prese vantaggio da quel suo azzardo, sebbene di poche centinaia di metri, e irruppe sulla successiva spianata come un tronco trascinato dalla piena. In quel punto la strada attraversava un pugno di case sparse, sparse tra i prati biancheggiavano pecore come nuvole innocue, qualche ragazzetto sbirciava il passaggio degli agonisti e una pattuglia d’oche presidiava il centro strada, stretta in una falange di lunghi colli e fieri becchi.
Picozzi puntò il plotone urlando, i volatili, sorpresi dall’irruzione, scantonarono con altissimo starnazzare di protesta, lui rispose con un ghignare roboante – Via! Via! Che vi strappo penne e piume! Via!…. – e assestò una pedata alla più vicina prima di sparire dietro l’ultima casa.
Le oche tornarono a radunarsi, parvero scambiarsi istantanee considerazioni, abbandonarono la strada e si precipitarono lungo il declivio, attraversato poco sotto dal tornante che Picozzi stava per affrontare in piena frenata. Le oche lo investirono dall’alto in un ribollire d’ali. Sorpreso dall’attacco aereo il Picozzi perse il controllo della bici e stramazzò a terra. Giudicando l’abbattimento del nemico non bastevole a lavare l’onta subita poc’anzi, l’indomita falange si rifece sotto, scaricando sul caduto una tempesta di beccate fino a sbrindellarne la divisa, poi si ritirarono fulminee sul prato sottostante. Picozzi si levò tra imprecazioni di rabbia e di dolore, passò in rassegna i danni subiti dalla bicicletta, trascurabili peraltro, e quelli ben più evidenti che lo segnavano in ogni punto del corpo. Digrignando e bofonchiando riprese la discesa mentre le oche si contendevano a tratti di becco il suo berretto, a mo’ di trofeo.
Frastornato e orbato dalle ecchimosi il malconcio sbagliò una seconda curva e finì nelle fratte. Ne emerse vieppiù martoriato per veder sfilare via il Grande, raggomitolato sul vetusto suo mezzo, lanciato al traguardo ormai poco distante.
Picozzi chiuse la contesa schiumante di rabbia, rifiutò sdegnoso i sanitari, pronti ad offrire gli opportuni linimenti anche se perplessi di fronte alle costellazioni di bugne bluastre di cui aveva coperti polpacci e braccia. Andò in cerca dell’antagonista che trovò seduto a terra, immobile e col capo ciondolante. Accanto a lui, anch’essa abbandonata a terra, giaceva la venerata bicicletta, col traverso spezzato in due tronconi.
La maschera rabbiosa di Picozzi si tramutò all’istante in un ghigno trionfale:
- E te l’avevo detto che ti s’apriva in due! – e rideva e urlava, la voce orribile di gracula, urlava: – Ci hai due monocicli, ora! Ma guarda che son vecchi! I monocicli… -
Lo rivedemmo poche volte ancora.
Qualche mattina si presentò con la sua tenuta fuori moda, il Grande Solitario, ma senza bicicletta. Nessuno ebbe mai animo di chiedere notizie: il glorioso mezzo era riparabile? E, nel malaugurato (ma probabilissimo) caso ciò non fosse possibile, ne avrebbe acquistato uno nuovo? O anche d’epoca, che potesse in qualche modo ricomporre un barlume dello spirito di quella coppia tragicamente separata.
Ma il Grande Solitario, quell’antico cavaliere dal caschetto di cuoio russo, lo sapevamo, mai avrebbe condotto al braccio altra dama.
Infine scomparve.
Si chiesero notizie, naturalmente, ma di quella altissima figura, inspiegabilmente, nessuno pareva mai aver registrato l’esistenza al di fuori dalla cerchia dei ciclisti.
In verità un adepto di pedale, spintosi su una inedita scorciatoia per recuperare tempo dopo una foratura, sostenne d’averne scorto la sagoma tra i pali d’una vigna, scheletrita su un poggio dominato da un cascinale. La fretta del momento e l’ingannevole lucore del tramonto, aggiunse costui, gli impedirono di accertare finalmente la misteriosa sorte del Grande. Fu solo un attimo, staccò gli occhi dalla strada, intuì quella smisurata presenza umana nel superare l’acme del poggio ma subito discese dall’altra parte, perdendone la vista.
La notizia ci attizzò. Smaniosi di scoprire dove l’antico compagno avesse deciso d’esiliarsi, partimmo alla caccia della riferita scorciatoia, guidati da colui che l’aveva percorsa giorni avanti.
Non la ritrovammo. Svanita.
L’avvistatore fu deriso pubblicamente: quel giorno nella borraccia doveva aver messo vino o altro alcoolico che l’aveva inebriato al punto di irretirlo con visioni e false percezioni. Fu l’unica occasione in cui si ebbe una notizia, benchè fallace, del Grande Solitario dopo la sua scomparsa. Nel nostro girovagare l’occhio
puntualmente indagava la campagna circostante, scrutava campi e casolari, scandagliava ogni orizzonte di glebe smosse. Infinite volte si credette di riconoscere il profilo ricercato, infinite volte si accertò d’aver sbagliato.
Molti anni sono passati e il tempo ci ha divorato. La sua fame cieca ha separato i più di noi dalle nostre amate due ruote. Poco per volta, ma inesorabilmente, i nostri nervi son diventati liane legnose, i muscoli fiaschette flosce e fior di farina s’è fatto l’antico vigore. Chi è rimasto subisce il supplizio di vedere quei pedali immoti, quelle meccaniche mute, quella catena che, legandoci di passione, ci rese liberi e votati al vento in faccia. La bici (che alienare sarebbe stato a lei estremo insulto) chiama invano da una cantina sotterra, dal buio solaio, dall’angolo del ripostiglio, tra mille altri reperti. Non possiamo risponderle che
con un flebile “Domani…sì, domani pedaleremo. Saremo di nuovo assieme nel vento…domani. Domani”.
S’accendono allora le forze, come sul limine d’un sogno. Ecco…le gambe mulinano senza più dolore, gonfiano i polmoni nell’aria sottile, danziamo nell’ascesa, poi giù, sbiechi per le curve, ad ali spiegate ed ebbri di vento e velocità.
Anche lui è tra noi.
Il Grande Solitario fila via sul curvo dei colli, come un essere immune al tempo ci porta a ruota per infinite distanze verso l’orizzonte, con fierezza consapevoli di un traguardo senza premio e non per incoscienza di ciò che là attende, com’è invece per i più.
Lunga vita al Grande Solitario!