Categorie: Arte e letteratura
Tags: I tesori di Guido Racconti storia antica
Scritto da: Guido Ghezzi
Commenti:1
MCCC
Questo è il quarto dei "Tesori di Guido" raccolti nella sezione d'archivio ad essi dedicata
MCCC
(di Guido Ghezzi)
Alcuni personaggi non hanno bisogno di far parte di un racconto, sono loro stessi il racconto.

Stamane ho perduto il mio specolo.
Mi è scivolato dalle mani mentre mi sistemavo i capelli seduta sulle rocce del promontorio.
Un’ape distratta ha sbattuto contro la mia spalla e mi ha spaventata, lo specolo m’è caduto sui piedi e poi è scivolato oltre il ciglio, giù verso il mare.
Non l’ho più ritrovato.
Era così bello! Con le due lunghe spighe appaiate a formare il manico…e Cerere pronuba dall’altra parte.
Me lo donasti di ritorno dalla Tracia, ricordi?
Era tra le mie cose più care. Una delle poche che mi è stato concesso portare con me quando mi hanno strappato dalla nostra casa sul colle. Quei vili mai avrebbero osato se tu fossi stato in vita! Neppure avrebbero percorso il decumano. Il solo saperti presente avrebbe fatto loro piegare le ginocchia, avrebbero mostrato la loro schiena di uomini senza onore.
Con la forza della loro viltà hanno violato l’uscio, profanato la nostra casa, battuto i domestici, sconciato con i loro sozzi passi i mosaici, strozzato il respiro all’orto.
Ma hanno esitato davanti alla tua effigie nel triclinio. Hanno sentito il tuo sguardo trafiggerli dall’Ade. E’ bastato questo a precipitare nel terrore quei miserabili! Non hanno più osato toccare un solo ninnolo! Hanno cessato le urla, ingoiato gli insulti, abbassato le armi e ho avvertito il tremito nelle loro voci quando mi hanno ordinato di seguirli fuori casa.
Mentre mi conducevano al porto ho letto sui loro volti. Sui loro volti di traditori servi del Traditore tutto era scritto a chiare lettere, non ho avuto bisogno di fare domande, di sfidare il loro disumano silenzio. Il loro silenzio colpevole e infame.
Ho capito cosa il Fato serbava per me: il Tiranno dunque mi esiliava. Dopo averti tolto a me completava il suo turpe disegno: mi toglieva alla mia casa e ai miei figli.
Egli mi ha relegato in mezzo al più vuoto dei mari, su questo grano di terra salata e infeconda, un masso scivolato via dalle mani degli Dei.
Mi ha imprigionato qui perché nulla potessi contro di lui.
Oh! Quanto sono stati ciechi i suoi occhi e sorde le sue orecchie! Ha creduto che il mio lutto celasse trame ai suoi danni per vendicare il tuo ignobile assassinio.
Quando ho riportato a Roma le tue ceneri in molti ti hanno pianto e a lungo.
Eri benvoluto.
Il tuo vivere nella semplicità, il tuo essere così vicino al popolo, la tua forza e i tuoi trionfi hanno scolpito la più grande delle statue. La tua morte in quella terra straniera, così lontana che neppure riesco ad immaginare la strada che laggiù conduce, è stata una folgore caduta dal pugno di Giove ed ha scavato un cratere senza fondo in quanti ti stimavano. E ancora il tuo nome si pronuncia con la deferenza dovuta a chi ha strappato l’aquila di Varo alle selve di Teutoburgo, con il rispetto che invocano le anime dei mille e mille legionari laggiù caduti, per l’infinita pietà con cui hai dato sepoltura alle loro ossa dopo tanto tempo. Quale romano ha fatto tanto per sottrarre quelle spoglie all’insulto straniero? Chi altro si è spinto nell’oscurità di una terra tanto ostile e indomita?
I tuoi detrattori non sono degni del nome di Roma, pusillanimi che volgono le spalle al nemico, lumache che strisciano nell’ombra del Tiranno.
Possano i loro nomi svanire nell’oblio.
Il popolo ama la sobrietà, la giustezza e la sincerità in colui che ne assume la guida, vuole guardare il volto del potere sapendo che esso non cela inganno né doppiezza. Per questo il Tiranno ed i suoi viscidi servi hanno veduto in te la minaccia più grande.
Che mai tu avessi manifestato la volontà di insidiarli, che tu fossi in sommo grado rispettoso delle nostre leggi, dello stato e del titolo imperiale non ha avuto importanza, perché era del tuo nome invocato dal popolo che il Tiranno aveva timore.
Rifiutai di bere dalla coppa che il Traditore mi offerse. Sì, duplice è stato il suo tradimento: dopo aver armato la mano dei sicari contro il figlio ha osato offrire alla vedova il suo vino!
Commisi l’errore di parlare come tu avresti parlato: con parole chiare e franche affinché a tutti fosse manifesto il mio pensiero e questo mi ha condannato.
Ma potevo tacere? Il mio cuore ha guidato le mie labbra e dato suono alla mia voce, e il mio cuore non appartiene a Roma né al Tiranno. E né Roma, né il Tiranno, né quanti ti hanno conosciuto sanno quanto io ho perso.
Stare qui è come soggiacere ad un incubo.
Sono avvinta da un turbamento mai conosciuto prima e mi sento costretta da mille radici di bronzo, costretta nel loro mortifero abbraccio, un abbraccio che tuttavia non mi soffoca: mi lascia uno spiraglio da cui il mio sguardo, benché a stento, filtra ed io riesco a vedere uno spigolo del mondo esterno. E questo fioco percepire l’immensa vita che questo mio turbamento preclude è terribile.
Terribile.
So che l’amarezza di certe mattine è ineludibile. Quante volte mi ha accompagnata come un’ancella dal volto di nebbia, una compagna incolore che mesce una bevanda sconosciuta, me ne porge una coppa che bevo perché ho una sete profonda, ma quella bevanda inaridisce ancor più le mie labbra, divora il mio ventre, buca il mio corpo. E questa voragine ingoia ogni colore, cancella ogni varietà tra i suoni, sfarina il tempo. E tutto si fa piatto, muto e livido e vorrei solo chiudere gli occhi per lasciare fuori di me questo lucore straniero…..
Questo cielo non ha spirito: è un lino opalescente che induce ad uno stordimento senza sogni oppure è un deserto turchese arido e liscio, dimentico delle nuvole.
Le nuvole…la forma delle nuvole: qual è?
Il loro enfiarsi senza corpo….senza corpo il loro scivolar via.
Le nuvole.
Le nuvole senza corpo.
La pioggia che manca, il sole feroce.
Feroce che prosciuga la mia pelle, moltiplica i miei anni.
La notte è un rifugio. Ogni cosa intorno a me si attenua, la sofferenza quasi indebolisce la sua stretta, ma questo non basta per riprendermi dalla stanchezza del giorno. E quegli uccelli senza forma….quegli uccelli che si nascondono nel buio e danno voce alle anime inquiete ghermiscono i miei pensieri e li trascinano lontano, dove non riesco più a seguirli.
E questo mare che non è mare, è un lago di oblio e non profuma e non conosce onda di tempesta ma solo vento che spiana e luce che spegne.
Questo mare dal colore eterno e dal suono ipnotico, quest’ondeggiare morto che fronteggia con la sicumera di un nemico invincibile l’ultimo cubito di terra lastricata, questo muro di nebbie che prosciuga lento e inesorabile anche i miei pensieri e li abbatte sulla spiaggia.
Sulla spiaggia come farfalle dalle ali sfibrate.
Come farfalle.
Come farfalle sfibrate.
Sì, è vero.
Ogni giorno in più che trascorro su questa briciola di roccia malferma pesa come un coperchio su un sepolcro e invano cerco uno spiraglio da cui scorgere i tetti di Roma, il loro calore, il loro declinare interrotto, il candore del marmo…oh! E il profumo degli unguenti….il corallo di fuoco….
Ma anche il ricordo delle piazze, il rotolare delle bighe, l’intrico dei mercati, la pace delle fonti….sbiadiscono nella mia memoria.
Ieri riconoscevo il rumore dei cerchi di ferro sulle strade, sentivo l’odore dell’acqua delle fontane, delle fontane.
L’acqua delle fontane.
Delle fontane.
Delle fontane.
Il mescolìo delle voci nelle vie, il rincorrersi delle parole.
Delle parole.
Delle parole.
E oggi….oggi fatico a ritrovare tutto questo nella memoria.
Ciò che rende oggi diverso da ieri sta solo nell’aver trascorso qui un nuovo giorno.
La sostanza della vita è ora tutta in questa arida differenza, altro non c’è che possa aiutarmi a distinguere un giorno dall’altro.
Oh che amarezza! Che amarezza pensare ora al tedio che mi angustiava in certe giornate sul colle, tra una tua partenza ed un tuo ritorno! Sono io ugualmente viva ora?
Di questo assottigliarsi del tedio è fatta dunque la nostra vita? Di un’attesa sempre distratta dagli accadimenti? Di un’attesa inconsapevole e inconsapevolmente ingannata nel fronteggiare mille accidenti?
Solo un altro giorno è passato ma così tanto mi ha tolto!
Quanto ancora verrà cancellato nei giorni futuri?
Quanto ancora dovrò sopportare?
E arriverà infine la mattina in cui berrò acqua appena sveglia e non ricorderò di averlo mai fatto nella mia casa sul colle?
Sarà un liberarsi infine dal supplizio! Non aver più nulla da consegnare all’oblio, non subire più questa mutilazione goccia a goccia: che gran giorno sarà quello!
Ma oggi sento il petto stringersi al solo pensiero e non riesco a sopportare questo peso. Ma non cercherò la morte, non so farlo. Questa è la mia debolezza e questa è la mia forza: non poter altro che resistere fino allo spirare delle forze, fino allo stingere ultimo della mente.
Non cederò al mio feroce persecutore, a lui non regalerò la vita che mi resta rendendola nelle mani di Atropo. Voglio che mi sappia in vita, che la mia prigionia resti il suo incubo, che sia il peso delle sue notti dorate. Non anelo alla sua morte, che viva pure nell’odio per me. Il suo livore è anzi la sua condanna. La morte lo libererebbe dal giogo che lui stesso s’è posto sulle spalle….
Ma il mio specolo…..che grave distrazione l’averlo lasciato cadere così!
L’unico volto che potevo incontrare se n’è andato in fondo al mare….
E come potrò ora far danzare la luce sulle rocce?
Con che cosa catturerò il sole per prendermi gioco dei pesci?
Lo amerei ancora, come amerei poterti scrivere.
Chiesi di potermi portare appresso uno stilo ed un volume: mi furono negati.
Il Tiranno lo sapeva.
Sapeva che non ho bisogno dello scriba, che so scrivere da me. Mi ritengono pericolosa persino in questa miserabile prigionia, hanno il terrore che scriva del loro sordido agire e che qualcuno un giorno legga. Non importa quanto ciò sia di fatto negato dalla situazione.
Vanitosi omuncoli! Non scriverei certo di loro.
Ieri ho pensato un distico e l’ho scritto sulla sabbia bagnata. E’ rimasto lì fino a sera, poi la marea l’ha portato via, come tanti altri. Stanotte lo ricordavo bene e l’ho ripetuto a lungo, ma oggi non lo ricordo più. Dimenticare vale quanto subire una nuova condanna ogni giorno.
L’avresti letto con piacere. E io ti avrei chiesto di leggermelo con la tua bella voce, che sapeva far danzare le parole.
La voce.
La voce tua è ciò che più mi manca.
La voce che non è parte del tuo corpo ma che diviene te nell’uscirne.
Cerco le tue mani nella notte, la loro forma nelle ombre che entrano nel mio rifugio.
E i tuoi occhi nel giorno, la loro luce scura nei golfi che stringono il mare.
Ma la voce è ciò che mi sforzo di ritrovare nella memoria più di ogni altra cosa di te.
Ad ogni risveglio temo di averla dimenticata e giaccio nell’angoscia. Così, nella veglia, tengo gli occhi chiusi fino a che non la ritrovo, fino a che non sento il suo calore scendere in me.
Solo dopo questo ritrovo la forza di levarmi dal giaciglio ed affrontare il giorno.
Il giorno.
I tanti giorni.
Non misuro il tempo in anni. Io non so cosa sia un anno, non posso averne sensazione, è troppo difficile da figurare, troppo lontano dai miei sensi.
Misuro il tempo in giorni, perchè un giorno ha un suo limite ben preciso, una durata che conosco bene, confini che posso vedere e toccare.
Posso toccare la linea che delimita l’ombra del promontorio stesa sulla sabbia umida e persino vederla mentre scivola oltre come un velo trascinato da un vento leggero. Vedo il giorno nella luce che si fa più forte, accende ogni cosa, la strema e poi sbiadisce. E’ come una scalinata bianca con i primi gradini posati nell’oscurità, poi sale alla luce piena, spiana e infine discende ancora nel buio.
Così so che mille e trecento sono le volte che ho calcato quei gradini.
Mille e trecento sono i giorni che ho passato su questo arido scoglio.
Mille e trecento sono i sassolini che ho raccolto.
Mille e trecento sono le sere che sono scesa verso il mare a sceglierne uno da posare nell’angolo del mio rifugio.
Quel monticello è la misura del mio tempo. A volte chiudo gli occhi, vi poso le mani e mi sembra di poter contare tutti i sassolini con il solo tocco delle dita. Ognuno è diverso ma ognuno è anche indistinto dagli altri: se li mettessi in fila e poi ne cambiassi l’ordine come a cambiare l’ordine dei giorni, il racconto che essi fanno della mia vita non sarebbe diverso.
Tranne che per uno.
In questo mio gioco uno dei sassolini non può essere spostato.
E’ diverso da tutti gli altri.
E’ il più bianco.
Il più levigato dal mare.
Il più lucente quando vi stilla una mia lacrima.
E’ quello che per primo ho tolto alla spiaggia.
Il primo giorno di questo esilio è stato duro come il primo giorno di una malattia: traboccante di sofferenza, di un angustiarsi del respiro nel petto. Duro perché latore di cose nuove ma orrende, duro perché il mio pensiero volava innanzi ai giorni nel tentativo di indagare i futuri avvenimenti, di averne una specie di previsione, di capire quando tutto avrebbe avuto fine e sarebbe tornata la mia vita di un tempo e nei miei pensieri c’era questa speme infinita di fuggire, di uscire infine da questo orrore.
Ma a poco a poco, come per un malato che veda i giorni passare senza un segno di guarigione e perciò si senta sempre più inseparabile dalla sua stessa malattia, questa per me è divenuta la vita di ogni giorno, l’orrore mi è entrato dentro, ha profanato il mio corpo.
Eroso la mia mente.
Stuprato la mia anima.
Ma ancora riesco a sentire che mi manchi.
Una fiammella di te è rimasta, piccola ma ardente.
E mi scotta.
E da questo dolore so d’esser viva, di non avere ancora assunto la forma di una testuggine che ignara s’interra e lascia le stagioni scorrere sul freddo carapace.
E continuerò ad aggiungere un sassolino ogni volta, fino a che non vedrò l’orizzonte rotto da una vela, fino a che essa non approderà nel golfo e mi porterà una notizia.
Saprò così che egli avrà perso il potere di nuocermi.
Oppure sarà un lungo disporre un sassolino accanto all’altro fino a rendere la spiaggia una liscia e perfetta distesa di sabbia. Allora annoderò la veste sul fianco e camminerò nel mare a prenderne un altro, sempre più lontano, sempre più nascosto nel fondo, sempre più solitario.
E uno ancora.
E un altro.
E un altro.

Questo racconto è ispirato ad una donna veramente esistita nell'antica Roma. Donna importante, di grande cultura e di potente spirito. Sfortunata, dovette soccombere alla violenza dell'intrigo imperiale ed alla condanna, ma visse fino all'ultimo giorno con orgoglio indomito. Si chiamava Vipsania Agrippina, figlia di Giulia Maggiore e pertanto nipote del Divo Augusto. Sposa del (secondo me) grande Germanico, figlio adottivo di Tiberio e da questi probabilmente fatto uccidere. Germanico e sua moglie Agrippina (detta "Major") hanno un posto speciale tra i miei ricordi di storia romana.



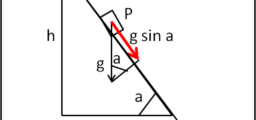


1 commento
Ottima rievocazione di poetico stile. Come un eco dal passato (politicamente non tanto remoto).
Più prosaicamente a me questo speculo ha fatto tornare in mente l'obiettivo che nel 1974 mi sfuggì di mano mentre fotografavo dalla cima del promontorio di Capo Ferrato (Costa Rei, Sardegna). Esso pure "m’è caduto sui piedi e poi è scivolato oltre il ciglio, giù verso il mare". Con gli occhi già bagnati da lacrime lo vidi saltellare di roccia in roccia fino al luttuoso tuffo nelle cerulee acque :-(